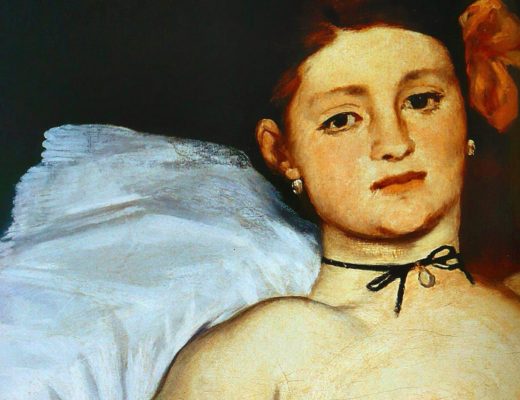È iniziato oltreoceano, in una piccola libreria indipendente. E poi, come un’epidemia – una febbre, per essere più esatti – ha contagiato tutto e tutti. A New York, la città delle mille luci, potreste incappare in uno dei tanti bookstores che espongono una teca – contenente quattro libri – su cui campeggia una scritta fucsia al neon. È la «Ferrante Fever»: il fenomeno che ha coinvolto milioni di persone sparse in tutto il mondo, che si sono ritrovate incollate alle 1728 pagine che compongono la tetralogia dell’«Amica geniale» pubblicata da Edizioni E/O.
Giacomo Durzi – sceneggiatore romano, attualmente impegnato nella realizzazione di Baby, la terza serie italiana originale distribuita da Netflix – ha deciso di raccontare il fenomeno Ferrante attraverso un film-documentario, intitolato appunto Ferrante Fever. Dopo aver conquistato spettatori per tre serate nei cinema di tutta Italia, sarà presto in onda per Sky Arte. Da New York a Napoli, dagli anni Cinquanta a oggi: muovendosi nello spazio e nel tempo Durzi tratteggia meravigliosamente una delle figure più enigmatiche della letteratura italiana. E lo fa con l’aiuto di grandi ospiti. Da Nicola Lagioia a Jonathan Franzen passando per Elizabeth Strout. E poi ancora: Roberto Saviano, Francesca Marciano e Ann Goldstein, la traduttrice americana di Ferrante.
In attesa della serie Tv tratta dalla tetralogia prevista per il 2018 – che porterà la doppia targa Rai-Hbo e sarà diretta da Saverio Costanzo – ho tentato, insieme a Giacomo Durzi, di risolvere il mistero. No, non il segreto che circonda l’identità di Elena Ferrante. Sto parlando di un interrogativo molto più profondo: è possibile, narrativamente parlando, raccontare un fantasma?
Un documentario su una delle figure più imprendibili e insieme più chiacchierate della letteratura italiana. Un fenomeno mondiale. Com’è stato ideare, scrivere e girare Ferrante Fever? Da dove nasce il progetto?
L’idea di farne un film-documentario nasce dalla mia passione per i suoi libri. Arrivato alla fine della tetralogia dell’Amica geniale ho iniziato a flirtare con il desiderio di approfondire meglio quella intensa esperienza di lettore che avevo vissuto. E così ho pensato di fare un documentario. Per capire cosa c’è all’origine di quel patto profondissimo e inconsueto che lega i lettori ai suoi romanzi. In un momento storico in cui la letteratura è sotto l’attacco dei media, mi interrogavo su cosa potesse generare interesse e coinvolgimento emotivo in uno spettro di lettori così vasto da coprire (letteralmente) mezzo mondo. Ho pensato allora di indagare questo fenomeno attraverso diverse testimonianze e, allo stesso tempo, attraverso le parole dell’autrice – tratte dal libro-memoir La frantumaglia – recitate da una voice-over, quella della splendida Anna Bonaiuto, che dialoga con gli ospiti intervistati.
In Italia sembra che l’anonimato sia l’aspetto di Elena Ferrante che interessa di più. All’estero invece – penso a Jonathan Franzen o Elizabeth Strout, che nel tuo film si dimostrano entusiasti ammiratori – al centro del discorso c’è la sua scrittura. Come spieghi questo slittamento di prospettiva?
L’anonimato di Ferrante è stato, dopo la notorietà raggiunta grazie alla tetralogia, il modo più comodo e pigro di parlare e gossipare sulla sua figura da parte dei giornali e di tutti i media. Credo che alla base ci sia questo, prima di tutto: un’enorme superficialità, condita da un mistero che genera interesse. Un interesse decisamente maggiore rispetto alla possibilità di comprendere le ragioni che stanno (e stavano in origine) dietro il suo anonimato. Spesso ce lo dimentichiamo, spinti dall’emotività scatenata dalle vicende di Lila e Lenù, ma ormai sono oltre vent’anni che Elena Ferrante ha scelto di non apparire. Nel resto del mondo è stato diverso perché – è banale dirlo, ma è vero – in un Paese come il nostro il successo non genera condivisione ma divide. Come diceva Enzo Ferrari: «In Italia si perdona tutto tranne il successo».
Il fatto che grandi scrittori come Jonathan Franzen o Elizabeth Strout abbiano contribuito a far conoscere le qualità dei romanzi di Elena Ferrante indica qualcosa di straordinario, sì, ma ci dice anche che alla base è presente una sana e autentica passione per la letteratura. Da noi, in Italia, si è invece determinato un processo diverso. L’equazione successo uguale mancanza di qualità purtroppo non è ancora stata superata. Ed è per questo motivo che Elena Ferrante è stata – ed è – spesso snobbata da parte della critica, quindi ho deciso di realizzare un documentario sulla sua figura e le sue opere.
Ferrante Fever segue le tracce disseminate da La frantumaglia, di fatto l’unico documento dichiaratamente autobiografico dell’autrice. Ed è come pedinare un fantasma. Il tuo lavoro è stato riempire i vuoti: come hai scelto le persone le cui interviste sono confluite nel documentario? Hai dovuto rinunciare a qualcuno?
I testimoni che ho chiamato a raccolta per narrare la «Ferrante Fever» sono tutte persone di notevole spessore (dei grandi numeri primi!). Ognuno a suo modo. Volevo comporre un puzzle di sguardi che esprimessero esperienze di lettura prima di tutto «qualificate», ma soprattutto esperienze di vita vissute attraverso l’opera di Elena Ferrante e la sua traduzione all’estero. Come per Matteo Garrone e Roberto Faenza che ne hanno tratto due film… Mi servivano voci in grado di restituire in parole precise tutta quella varietà di sentimenti che ognuno prova leggendo i libri di Ferrante.
La «Ferrante Fever» è scoppiata a New York ed è da lì che parte il tuo documentario. Come hai costruito il ponte con Napoli?
Sono partito da New York per poi tornare indietro nel tempo, perché ho pensato fosse la chiave di interpretazione più giusta, anche per esprimere il mio punto di vista sul fenomeno. Lo ribadisco: in Italia non siamo stati in grado di sostenerla e apprezzarla. Ecco perché Ferrante è diventata una voce familiare anche (e soprattutto) per molti lettori a New York. Con Napoli, poi, il ponte è venuto naturale. Tutto nasce da quella città: ho solo dovuto stare attento a non cadere nello stereotipo mentre la rappresentavo. Napoli è una città meravigliosa, ma difficilissima da raccontare per immagini e parole. Ferrante ci riesce ribaltando gli stereotipi. Io non ho fatto altro che lasciarmi condurre dalle parole dei miei intervistati – come Garrone in particolare – e quelle di Ferrante stessa scelte, come detto, da La frantumaglia.
La vera identità di Ferrante è un mistero che in molti hanno tentato di risolvere. In Ferrante Fever sei stato molto rispettoso del suo anonimato, e dei nomi che sono stati fatti da quando L’amore molesto è stato dato alle stampe. Tu vorresti sapere chi è davvero?
Non mi interessa più sapere chi sia Elena Ferrante. Ho realizzato il film proprio perché smettessimo di chiedercelo. Perché non ha importanza. Fondamentale invece è capire quanto la sua scelta sia stata rivoluzionaria e quanto ci abbia insegnato qualcosa di molto utile in tempi come questi.
Hai cercato di metterti in contatto con Elena Ferrante tramite il suo editore? Lei ha visto il documentario, ti ha fatto sapere cosa ne pensa?
Attraverso gli editori abbiamo saputo che Elena Ferrante ha visto il documentario. E sì, le è piaciuto.