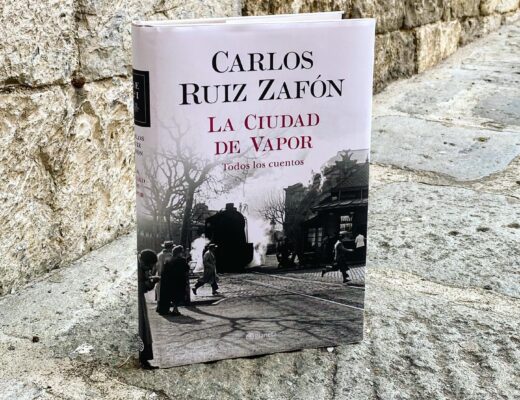Lo sguardo di un padre, Davide, lontano ma presente, guida il lettore alla scoperta di quel fragile microcosmo che è la sua famiglia. La moglie Elena, Sara, frutto di una precedente relazione e, infine, il piccolo Andreas: un nido da proteggere dallo squallore del mondo esterno.Sono questi gli elementi che compongono l’ultimo romanzo dello scrittore milanese Giuseppe Munforte, Nella casa di vetro (Gaffi editore, pagg. 198, 14.90 euro). L’amore incondizionato per i propri cari permea ogni parola del narratore, ogni singolo gesto. Un amore reso visibile grazie alla sensibilità dello scrittore che trasforma il romanzo in una delicata poesia.
Esiste la casa di vetro? Nel descriverla ha pensato ad una casa in particolare o ha esemplificato tratti e caratteristiche di diversi luoghi in cui ha vissuto?
Non ho mai scritto di luoghi, di persone, di ambienti che non conoscessi, quanto meno per averli sfiorati. Per quel palazzo di cui si parla nel libro, ho pensato a una casa dove ho vissuto per diversi anni. Un luogo molto simile a quello del racconto, a ridosso della provinciale per Milano, con le stesse caratteristiche descritte nel libro. Però la materia poi nella narrazione si trasforma tanto che credo nessun lettore riconoscerebbe quella casa, vedendola davvero.
Ha iniziato la stesura del libro alla fine del 2000. Com’è nato il romanzo e, soprattutto, come si è evoluto nel corso degli anni? Come è cambiato?
La prima versione, come ho detto nella nota, è nata in un tempo relativamente breve. Poi, con gli anni, da un lato ho rivisto i “quadri” che compongono la narrazione in prima persona, cercando anche di trovare la giusta sequenza, per lo sviluppo della vicenda e dell’evento che la guida. Parallelamente ho scritto le parti in corsivo, in terza persona, per delineare verso il futuro la storia, e la personalità, dei vari protagonisti. Il libro, come tutti i romanzi che ho scritto, è nato senza avere all’origine un’idea precisa, senza un progetto definito.
Nella casa di vetro affronta la tematica del nido, della famiglia. In una società frenetica e divisa come la nostra, crede che questo tema, così ampiamente affrontato in letteratura, possa acquisire una valenza, un significato nuovo, particolare?
Prima ancora che della famiglia, credo che il romanzo parli dell’amore, e della paternità, ossia di quelle esperienze nelle quali in modo più evidente si rompe – in una direzione ricca, piena di suggestioni – la distanza dal mondo, l’estraneità che spesso caratterizza la nostra esistenza. Questo avviene, come dici tu, anche per contrasto a quello che circonda le nostre relazioni più intime: una condizione ambientale e sociale spesso tremenda, spietata.
Lo stile narrativo è evocativo e poetico: le parole sembrano scelte con cura, soppesate una ad una. Perché ha utilizzato un linguaggio di questo tipo? Questa scelta linguistica vuole essere un riflesso della delicatezza del tema affrontato, quello degli affetti?
Anche lo stile non è stato scelto a priori, è venuto “naturalmente” dalla posizione del narratore nei confronti di quello che descrive. È come se volesse toccare con le parole. Una posizione di massima prossimità e, allo stesso tempo, di irrimediabile distanza. La sua è una voce che nasce, in un certo senso, da una condizione di contemplazione, nel senso più profondo che possiamo dare a questa parola.
Prima ancora che della famiglia, credo che il romanzo parli dell’amore, e della paternità, ossia di quelle esperienze nelle quali in modo più evidente si rompe – in una direzione ricca, piena di suggestioni – la distanza dal mondo, l’estraneità che spesso caratterizza la nostra esistenza.
In molti hanno definito Nella casa di vetro una favola moderna, metropolitana. Crede che sia la definizione più corretta per esemplificare il suo romanzo? O che in qualche modo lo sminuisca?
Non credo che questa definizione sminuisca il romanzo. Le fiabe in genere ci dicono quello che sentiamo essere vero ma che non ha riscontri nella realtà. È fiabesco, se vuoi, il filo che collega tutte le cose che vengono raccontate e descritte, il modo in cui il narratore le percepisce. Il suo lieto fine è distribuito ovunque, non si trova al termine del racconto.
Il lavoro è visto negativamente, come un qualcosa che non dà soddisfazione personale, che, semplicemente, toglie tempo alla famiglia, più in generale agli affetti. Perché ha voluto sottolineare così aspramente questa dicotomia?
Il lavoro per i protagonisti del libro è il correlato sociale di quello che li circonda fisicamente. La loro vita cresce e trova senso come certe piante, per usare un’immagine abusata, vivono incuneandosi e aprendo varchi tra le pietre.
Il rapporto tra Davide e la moglie Elena è molto particolare. Quest’ultimo accetta anche Sara, la bambina che Elena porta in grembo, non sua. È con lei che Davide condivide i momenti più dolci. Ho notato un legame fortissimo, paradossalmente più intenso di quello con Andreas, figlio naturale.
Ho voluto sottolineare quanto l’amore, che è una forma positiva di sradicamento, di liberazione verso possibilità e potenzialità che altrimenti restano sopite, inespresse, sia legato a fattori incontrollabili e diversi da quelli del dato materiale, come ad esempio il legame genetico, che è illusorio proprio in quanto semplice causalità materiale, insufficiente a generare un’esperienza così grande come la paternità.
Il romanzo è stato candidato ad uno dei premi più importante nel panorama letterario italiano, il Premio Strega. Come ha vissuto questa esperienza?
Con stupore. Non mi sarei mai aspettato potesse accadere. È stato un successo essere entrato nel gruppo dei finalisti, viste le premesse. Per quanto mi riguarda, tutto si sarebbe potuto fermare alle schede di presentazione, di Arnaldo Colasanti e Massimo Raffaeli, bellissime, e nate semplicemente dalla lettura del libro. Un successo anche i tredici voti della selezione per la cinquina, perché assolutamente non dovuti, non previsti, nati da una scelta libera dopo la lettura. In definitiva lo Strega è stata una bella avventura, anche umanamente, per come l’ho vissuta insieme agli amici della casa editrice.