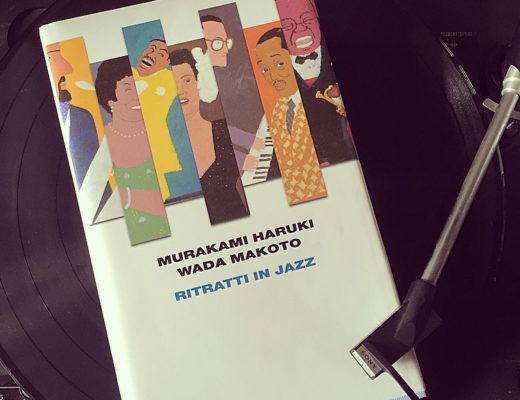Ci sono storie che sembrano destinate a perseguitarti, rincorrerti, e infine trovarti. È questo il caso de Il grande animale (nottetempo, pp. 161, 12 euro), opera prima di Gabriele Di Fronzo. In un susseguirsi di capitoli brevi – gorghi nei quali il lettore viene inesorabilmente intrappolato – Di Fronzo intesse una storia di perdita, ossessione e morte. Francesco Colloneve, imbalsamatore di professione, si ritrova ad accudire il padre anziano la cui memoria sembra venire smangiucchiata un po’ alla volta dai tarli del tempo e della malattia. Ma la perdita del genitore amato e odiato spingerà Colloneve – maestro nel rendere immortale ciò che è destinato a essere così tristemente mortale – a utilizzare ogni strumento a sua disposizione per superare (e accettare?) un dolore che non può essere in nessun modo consolato. L’opposto di una storia d’amore, insomma: boy leaves girl. Perché, sembra suggerirci Di Fronzo, la forza sorgiva delle storie è tutta lì. Racchiusa nell’abbandono.
Francesco Colloneve è nato subito tassidermista?
Credo che non ci sia stata quasi distanza tra il momento in cui ho deciso di raccontare una storia di perdita e quello in cui sono arrivato a riconoscere nel tassidermista il giusto protagonista del mio romanzo. Fin dall’inizio questo personaggio era presente. Un tassidermista, con la sua gestualità puntiforme, la reiterazione ossessiva, avrebbe occupato emotivamente a tono quello stato di incertezza e di inquietudine di chi sta per perdere o ha appena perso qualcuno o qualcosa senza cui reputa di non essere più in grado di vivere.
Del resto molto di ciò che facciamo quando perdiamo una persona cara ha a che fare con i rituali. La ripetizione compulsiva di certi atti che ci consentono di ricordarla (non di riportarla in vita, ma è questa la frode con cui ci illudiamo) è di conforto. Francesco Colloneve, il protagonista di Il grande animale, si è andato quindi sempre più affinando come una figura liminale tra l’età del possesso e quella della perdita.
Qual era il tuo rapporto con la tassidermia prima de Il grande animale?
Prima di iniziare a lavorare a Il grande animale non sapevo nulla di imbalsamazione. Non avevo mai visto qualcosa di impagliato – se non qualche testa di cinghiale o cervo nei salotti di alcuni cacciatori. Quando ho deciso di occuparmene, per prima cosa sono andato al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, la mia città. Ho trascorso giorni e giorni nel museo a riempirmi e calibrare gli occhi: passeggiavo lungo i corridoi, di sala in sala, osservando tutti gli esemplari dell’ampia collezione esposti. All’inizio da neofita mi sembravano tutti simili, poi un po’ alla volta lo studio dei manuali di tassidermia mi ha permesso non solo di conoscere le tecniche necessarie, ma anche a riconoscerle negli animali esposti nel Museo. Mi ero infine assegnato un’occasione di sguardo competente e peculiare.
Come ti sei documentato?
Ho prestato servizio civile presso la Biblioteca Civica di Nichelino – una piccola città nella prima cintura torinese – in concomitanza con l’inizio del mio lavoro sul romanzo. Quell’anno è stato un periodo foriero di possibilità e di esiti insperati e imprevedibili. Avevo a disposizione qualsiasi libro che non conoscessi: bastava girare l’angolo da uno scaffale e il successivo e potevo consultare tutto ciò che volevo e che non conoscevo. Il catalogo della biblioteca a mia disposizione ogni giorno: come aver avuto sul comodino affianco al letto una pila di sedicimila volumi. Passavo le ore a spulciare tra i titoli per vedere se ci fosse qualcosa che potesse interessarmi, selezionavo tutte le mie letture in base a quello che ritenevo utile per scrivere questa storia. Detto ciò non so su quali romanzi o saggi si incardini il mio. Con buone probabilità su quelli che io ho ormai dimenticato di aver letto.
Credo che non ci sia stata quasi distanza tra il momento in cui ho deciso di raccontare una storia di perdita e quello in cui sono arrivato a riconoscere nel tassidermista il giusto protagonista del mio romanzo.
La letteratura quando ha provato a raccontare l’imbalsamazione?
Un racconto di H. G. Wells, uno di Norberto Luis Romero scoperto poco fa. Un albo di Dylan Dog. Un cane imbalsamato con in bocca un giornale arrotolato c’è in un romanzo di James Ellroy. Un gatto in un romanzo di Simenon. Per dirne giusto una manciata. Ad un certo punto mi sono infatti reso conto che gli animali imbalsamati nei romanzi ci sono spesso. Figure ornamentali, difficile andassero oltre. Ho rinvenuto tantissimi esemplari impagliati nella letteratura degli ultimi due secoli, ma non un romanzo tagliato su un tassidermista. Non mi stupirei esistesse, io però non l’ho scoperto finora. L’imbalsamazione nei racconti e nei romanzi era più di corredo, come se ci fossero tantissime teste, ma non venisse mai rappresentato l’animale a figura intera con al suo fianco l’uomo che lo aveva messo in posa.
Come hai trovato la voce di Francesco Colloneve?
La voce riflette il suo mestiere, c’è continuità tra mani, cervello e bocca di quest’uomo. Come se una cordicella invisibile li legasse irrimediabilmente. Questa lingua scabra ha tanto a che fare con la professione quanto con lo sguardo autistico che Colloneve ha nei confronti della realtà. Credo si possa dire che questo è un romanzo di voce: ciascun paragrafo è un gorgo nel quale entriamo perché rimaniamo ammaliati in maniera sofferente, incombente, sottile dal soffio a suo modo vitale di questo personaggio. Se non avessi trovato la voce, Il grande animale avrebbe avuto gambe così gracili da non riuscire ad avere la forza per andare incontro ai propri lettori. Me ne sarei accorto e l’avrei abbandonato. Francesco Colloneve è un uomo sano solo per se stesso. Qualunque altra persona lo guardasse, lo troverebbe pieno di guasti, di zoppie. Ma lui è irreprensibile, è devoto a se stesso perché pensa che solo il suo e quello di nessun altro sia il modo corretto di comportarsi.
La sua, del resto, è una grande finzione.
Fingo in latino vuol dire costruire. Quella di Colloneve è una grandissima costruzione, usa le mani per trasformare ciò che prima del suo intervento era morto. Il fatto che la sua opera possa eventualmente rimanere incompiuta ci interessa poco. Del resto l’incompiutezza è una delle cose più diffuse tra gli esseri umani perché la si possa considerare dirimente. A me deve interessare che lui ci provi. Lui che intende cesellare un galateo comportamentale per sopravvivere alla perdita del padre.
Se non avessi trovato la voce, Il grande animale avrebbe avuto gambe così gracili da non riuscire ad avere la forza per andare incontro ai propri lettori. Me ne sarei accorto e l’avrei abbandonato.
L’assenza come continua presenza. Ci dici qualcosa dei personaggi femminili?
Francesco Colloneve non ha rapporti con altre donne. Conosce il sesso, come molto altro, solo attraverso gli animali. I suoi maestri sono loro. Lui ha a che fare con la gestazione, con la nascita, con i rapporti sessuali tra bestie: il libro è disseminato di episodi di questo tipo e sempre hanno a che fare col guasto, il fallimento (le due farfalle che muoiono mentre si stanno accoppiando, l’uovo della gallina che esce fuori senza guscio) e poi la madre che ha lasciato lui e il padre tanti anni fa. L’idea di un’impossibilità a essere figlio è presente anche nella rappresentazione di questi animali rovinati.
Dorothy Parker diceva che tutti gli scrittori scrivono della loro infanzia. Tu hai passato moltissime ore, da bambino, al Museo Egizio di Torino. Credi che questo, in qualche modo, ti abbia condotto fino alla storia di Colloneve?
Mio padre fino a qualche anno fa ha lavorato lì e io ho vissuto così in prossimità con quel mondo da patirne una qualche fascinazione. Da bambino ci sono stato decine e decine di volte l’anno, e stessa cosa da ragazzo: quando passavo dal centro di Torino una breva incursione era difficile che me la negassi. Ho anche trascorso lì qualche notte, a dormire su una brandina, tra sarcofagi e mummie e vasi canopi. Già. Ricordo gli ushabti, le statuette che gli Egizi ponevano a fianco del defunto per fare al posto suo tutti i lavori che avrebbe dovuto svolgere nell’oltretomba. La mummificazione, i vasi canopi, il libro dei morti. Rituali di mnemotecnica che davano permanenza agli individui innanzitutto dal punto di vista fisico. Ma c’è da dire che durante la scrittura non sono stato affatto consapevole che questo magnetismo egizio mi stesse influenzando. E non sono certo neppure tuttora se ciò è avvenuto o meno per davvero.
Fotografia © Francesco Berti