Chiunque sia stato attraversato dal dolore della perdita e abbia affrontato la nuova quotidianità dettata dai ritmi della malattia non potrà che ritrovarsi nelle pagine de L’invenzione della madre (minimum fax, pagg. 280, 14 euro), romanzo d’esordio di Marco Peano.
Pagine che racchiudono il lungo addio di un figlio, Mattia, verso la madre malata – scandite in un prima, un durante e un dopo – colme di verità e rispetto, che rifuggono quei meccanismi di facile retorica in cui, spesso, si cade affrontando temi così complessi e intimi. È stata definita, quest’opera prima, una corsa contro il tempo di un figlio che lotta contro il cancro della madre per cercare di assaporare pienamente ogni istante rimasto. Corsa che presuppone, al tempo stesso, un brusco arresto, un cambio di direzione di Mattia, ventiseienne dipinto come apatico, insicuro, fragile.
Un protagonista, verso il quale Peano non mostra il minimo accenno di pietas, che decide di fermarsi – di premere il tasto stop del film che chiamiamo Vita – per restare accanto alla madre. Ma lasciare in sospeso sogni, aspirazioni, affetti e decidere di prendersi cura attivamente di una qualsiasi persona amata che sta morendo è, di per sé, un atto di grande coraggio.
E nel tentativo – riuscito ed estremo – di risultare cinico e distaccato nei confronti del suo personaggio, Peano restituisce pienamente l’umanità che ci contraddistingue quando siamo posti di fronte a quel dolore che tutto fagocita. Un’operazione resa possibile grazie alla straordinaria precisione nell’uso della lingua. Ogni singola parola è scelta con cura, quasi ossessivamente ponderata e infine incastonata nel testo con una scrupolosità da artigiano, di chi, per anni, facendo l’editor, si è preso cura delle storie altrui.
Ogni singola parola è scelta con cura, quasi ossessivamente ponderata e infine incastonata nel testo con una scrupolosità da artigiano, di chi, per anni, facendo l’editor, si è preso cura delle storie altrui.
Da editor a scrittore. Cosa l’ha spinta a compiere questo passaggio?
Far nascere i romanzi degli altri e farne nascere uno proprio sono due attività che hanno entrambe a che fare con il prendersi cura delle storie, con l’attenzione, la ricerca e anche l’ossessione per le parole. L’invenzione della madre è un romanzo che scaturisce da un’esperienza autobiografica che ho rielaborato letterariamente, un romanzo che ha avuto una lunghissima gestazione. Mia madre è morta nel gennaio del 2006, esattamente come la madre di Mattia – le date coincidono. Ho iniziato a scrivere questo romanzo circa un anno dopo, nel gennaio 2007. La scrittura era dolorosa, attraversavo dei periodi in cui stavo molto male.
Facendo l’editor, spesso mi era impossibile tenere i due percorsi contemporaneamente. Non riuscivo a lavorare sulle storie degli altri e poi sulla mia. Se, tutto il giorno, stai frequentando la voce di uno scrittore e stai facendo attenzione alla sua storia, quando torni a casa la sera non hai – o almeno non avevo io – le forze necessarie per scrivere qualcosa di personale. Questo ha significato fare una scelta precisa: scrivere per sette anni, ma solo in alcuni mesi specifici (agosto e dicembre). Tutte le vacanze estive e quelle di Natale degli ultimi sette anni della mia vita sono state a contatto con questa storia. Nel corso dell’anno, invece, non scrivevo: raccoglievo informazioni, pensavo, leggevo. Un terzo binario rispetto al lavoro dell’editor e quello della scrittura era infatti quello della ricerca: in quei mesi cercavo di leggere tutto quello che poteva servirmi per raccontare questa storia. E il materiale era sterminato perché un tema come la morte di un genitore, l’elaborazione del lutto, la difficoltà nell’accettare il cambiamento permea la storia della letteratura quasi in modo totale. Per molti anni ho gelosamente tenuto lontano questo testo da sguardi estranei. Non ero sicuro di me e, avendo a che fare con la narrativa per motivi professionali, ero molto esigente. Rileggevo e non ero soddisfatto. All’inizio non pensavo neanche che potesse diventare un romanzo. Poi mi sono reso conto che c’era bisogno di un occhio esterno. Anche se faccio questo lavoro da diversi anni, è stato necessario confrontarmi con un editor perché non vedevo più le cose. Ero talmente immerso nel testo che la distanza non c’era più. Come quando un obiettivo di una videocamera si avvicina troppo all’oggetto e sfuoca tutto il resto. C’era bisogno di prendere le distanze.
Mattia è l’unico personaggio con un nome proprio presente nel testo. Perché questa scelta? Per dare un respiro più universale alla storia che stava scrivendo o per concentrarsi ulteriormente solo sullo sguardo del protagonista?
Credo entrambe le cose. È una storia molto privata, ma con un contorno decisamente universale. La malattia, e tanto più la morte di un genitore, riguarda – più o meno da vicino – tutti. Uno dei motivi per cui ho scelto di avere soltanto il nome del protagonista come perno centrale è perché quando noi soffriamo, quando il dolore – non necessariamente legato alla malattia – ci attraversa in maniera profonda, si radica in noi. Il mondo intorno allora è quasi come se scomparisse. Tutti quanti diventano figure di contorno: il padre, la madre, la fidanzata, la nonna, anche il gatto non hanno nome in questo romanzo. Perché l’egoismo che suscita un dolore profondo porta a cancellare tutto il resto. A fare diventare tutto brusio di sottofondo. Quando soffriamo diventiamo persone insopportabili perché ci concentriamo solo su noi stessi. Mi piace la tua chiave di lettura dell’universalità del progetto, però l’esigenza era anche quella di trovare la distanza giusta per poter raccontare questa storia.
Uno dei motivi per cui ho scelto di avere soltanto il nome del protagonista come perno centrale è perché quando noi soffriamo, quando il dolore – non necessariamente legato alla malattia – ci attraversa in maniera profonda, si radica in noi. Il mondo intorno allora è quasi come se scomparisse. Tutti quanti diventano figure di contorno: il padre, la madre, la fidanzata, la nonna, anche il gatto non hanno nome in questo romanzo. Perché l’egoismo che suscita un dolore profondo porta a cancellare tutto il resto.
Generalmente, si pensa che l’affrontare la malattia e la perdita di un genitore, acceleri, in qualche modo, il processo di crescita. Mattia invece si trova quasi cristallizzato in un limbo post-adolescenziale.
Il libro si intitola L’invenzione della madre. Da un lato, l’ho scelto perché mi piacciono moltissimo i titoli che hanno una parvenza di saggio, ma forme narrative, come La manutenzione degli affetti di Antonio Pascale. Ragionando sui vari titoli, avevo preso in considerazione persino Guida alla morte in provincia, che è diventato un titoletto nella prima parte delle tre di cui il romanzo è strutturato. Alla fine, la scelta è ricaduta su L’invenzione della madre. Mi piaceva la valenza oggettiva e soggettiva del genitivo nel titolo. Se, da un lato, è vero che a causa dell’assenza di un genitore – della madre – un figlio è costretto a inventarsela, a sua volta, il figlio è l’invenzione di sua madre. Inoltre, il verbo invenire, cercare, è qualcosa che sembrava tracciare un percorso all’interno della narrazione. Mattia si prende cura della madre, decide di stare fermo lì con lei, come spesso è stato fermo nella sua vita, perché forse un po’ fa diventare la malattia un alibi. Un alibi che gli permette di rimanere cristallizzato in quella fase che potremmo definire come post-adolescenza. Ha ventisei anni, un’età in cui si è a metà strada tra il non essere più un ragazzo e il non essere ancora uomo. Questa situazione crea quasi un cortocircuito perché Mattia prende il ruolo di sua madre e diventa suo genitore, ma prende anche il ruolo di suo padre, diventando una sorta di sposo della madre.
Il dolore che cade addosso al protagonista lo costringe a fermarsi per provare a decifrarlo. Il tempo del lutto è qualcosa di molto soggettivo. Da qualche parte ho letto che in alcuni uffici pubblici, si cercava di stabilire quanto un dipendente dovesse stare a casa in seguito a un lutto. Tre settimane bastano? Tre mesi sono sufficienti? Per quanto riguarda Mattia, il libro si interrompe poco prima dell’anniversario della morte della madre. Non sappiamo esattamente se lui riuscirà a seguire il suo sogno, ad abbracciare il futuro. Non sappiamo se davvero crescerà, quanto e in che modo. C’è da dire che il percorso che l’ha condotto fin lì gli ha permesso di portare dentro di sé un bagaglio di esperienze che ci auguriamo lo facciano diventare finalmente adulto e, magari, a sua volta, genitore.
Alla fine, la scelta è ricaduta su «L’invenzione della madre». Mi piaceva la valenza oggettiva e soggettiva del genitivo nel titolo. Se, da un lato, è vero che a causa dell’assenza di un genitore – della madre – un figlio è costretto a inventarsela, a sua volta, il figlio è l’invenzione di sua madre. Inoltre, il verbo invenire, cercare, è qualcosa che sembrava tracciare un percorso all’interno della narrazione.
Diverse parti del testo sono scritte tra parentesi. Perché ha scelto di usare questo espediente stilistico?
Avrei due risposte possibili a questa domanda. La prima è che il segno grafico della parentesi sembra quasi una pancia. Una pancia che contiene tante parole. Tutto ciò che è compreso tra due parentesi, metaforicamente può essere considerato come se fosse una gravidanza. E, dal momento che, il tema del materno è profondamente innervato nel romanzo, sarebbe stato interessante provare a mettere tante gravidanze nel testo. Questa riflessione, però, è avvenuta solo a posteriori.
In realtà, all’origine di questo espediente, oltre al fatto di piacermi molto la parentesi come segno di punteggiatura, c’era la possibilità di fare una scelta particolare. A scuola ci insegnano che quello che è tra parentesi è meno importante, è una cosa che si può anche omettere, che si può non raccontare. Se metti una cosa tra parentesi e, dentro, inserisci qualcosa di più significativo, è come se stessi facendo brillare di luce diversa quel qualcosa e costruissi una narrazione sotterranea che, in realtà, spesso è quasi più importante di quella principale. Se tu provassi a togliere tutte le parti che non sono tra parentesi nel libro e leggessi solo le parti tra parentesi, la storia funzionerebbe. Ovviamente con meno riferimenti, in modo diverso, ma funzionerebbe. Se tu facessi l’esperimento contrario, togliessi tutte le parti che sono tra parentesi tenendo solo le altre, il testo sarebbe molto più lineare e scenderebbe meno in profondità. La parentesi è un modo pudico per dire cose importanti, è quasi come se, anziché urlarle, le sussurrassi perché sono più preziose.
«L’invenzione della madre» è costellato di richiami al mondo del cinema. In altre interviste ha sottolineato come il dare a Mattia questa passione sia stato un espediente per farlo allontanare dal suo mondo, dal mondo delle parole. Alla fine del romanzo però, è Mattia stesso a constatarne l’importanza, quasi si volesse ricongiungere a lei, con una frase pregna di significato: «la realtà non sta nelle immagini, come ha sempre creduto, ma nelle parole».
Volendo ragionare sui meccanismi narrativi, ho deciso di dare a Mattia questa passione che, in parte, è anche mia. Un espediente che mi ha permesso di fare dei riferimenti a vicende altrui: i film sono dei contenitori di tempo, di vite, di esperienze e di affetti. La storia del cinema è per Mattia un’occasione per allargare questo tempo che inesorabilmente continua a scorrere e che porterà verso l’esito tragico della perdita di sua madre. Nell’anno successivo alla morte della madre rimangono solo gli oggetti a parlare, o peggio le persone che, intollerabilmente, continuano a esistere. Mattia ragiona sull’uso che facciamo dei ricordi, e su come usiamo le parole. Perché se da un lato è vero che le immagini sembrano essere qualcosa che immortala, che eternalizza, che fa diventare per sempre vive nella memoria le persone che non ci sono più; dall’altro Mattia capisce che le parole sono tutto quello che gli arriva da sua madre. Del resto, «mamma» è spesso la prima emissione vocale che, nella lallazione, i bambini imparano a dire perché è un suono molto facile.
Per quanto riguarda me, non avrei mai voluto fare un finale in cui Mattia si mette a scrivere un libro ed è il romanzo che tutti noi stiamo leggendo. Essendomi trovato anche io, come Marco Peano, cristallizzato a lungo in un periodo post-adolescenziale, ho capito che dovevo ricorrere a quello che sapevo fare, a quello che amavo fare: maneggiare le parole e prendere il coraggio necessario per dipanare questa storia. Era un modo per dire che Mattia, alla fine del romanzo, non sta iniziando a scrivere il libro ma ha finito di scrivere quello stesso testo e si ricongiunge, in qualche modo, a me. Lui, in quell’anno che ho raccontato, faceva un lavoro di cui non gli interessava molto. Io invece, mentre mia madre stava morendo, stavo facendo un lavoro che già amavo. Avevo il contatto con le parole, ma mi sembrava che non fossero sufficienti per aiutarmi, non erano il balsamo che speravo. Invece, dopo, ho capito che l’aver continuato a fare il lavoro che faccio, anche durante la malattia di mia madre, in qualche modo, mi ha salvato.
Mattia ragiona sull’uso che facciamo dei ricordi, e su come usiamo le parole. Perché se da un lato è vero che le immagini sembrano essere qualcosa che immortala, che eternalizza, che fa diventare per sempre vive nella memoria le persone che non ci sono più; dall’altro Mattia capisce che le parole sono tutto quello che gli arriva da sua madre. Del resto, “mamma” è spesso la prima emissione vocale che, nella lallazione, i bambini imparano a dire perché è un suono molto facile.
Dopo un romanzo così importante e con una forte componente autobiografica, sarà possibile scrivere e dedicarsi a un’altra storia, a un nuovo libro?
Questo è il libro che uno vorrebbe non mai aver scritto. Avrei preferito che il mio romanzo d’esordio parlasse d’altro. Invece parla di questo e sono comunque contento che sia così. La libertà che ti dà il primo libro è qualcosa di potentissimo, corroborante. Non saprei darti una risposta precisa. Le storie abitano in me da talmente tanto tempo…
Non avevo scritto un romanzo prima di questo. Avevo scritto dei racconti qua e là. Avevo fatto delle prove. Per la mia formazione professionale, mi è capitato di scrivere, e so che mi capiterà ancora. Non sono sicuro di aver esaurito l’argomento. Erano talmente tante le cose di cui parlare che le ho dovute concentrare. La prima versione di questo libro era di quasi 600 pagine. Era un mostro dal quale ho tolto, prima da solo, poi con i miei editor, parte del materiale che era di troppo. Ma tutti questi piccoli semi che sono stati gettati continuano a lavorarmi dentro. Mi piacerebbe anche provare a stare da tutt’altra parte, fare qualcosa di intentato. Quello che ha di bello la scrittura è che non raggiungi mai un traguardo. Sei sempre in cammino.




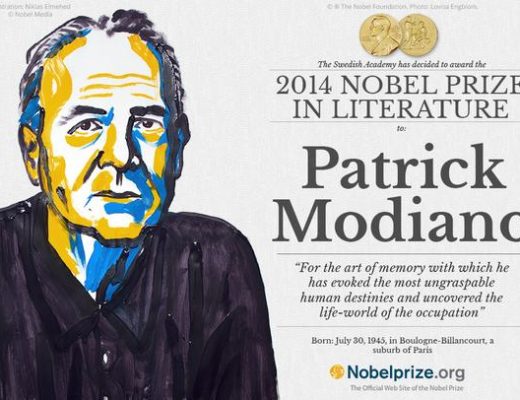
L'invenzione della madre di Marco Peano - Recensione | Fischidicarta Online
3 Ottobre 2016 at 16:58Diffuso è anche l’uso della parentesi, perché, come dichiara Marco Peano in un’intervista a Nuvole d’inchiostro: «La parentesi è un modo pudico per dire cose importanti»